Disporre correttamente la vela al suolo è semplicemente fondamentale per poter effettuare un corretto
gonfiaggio (ed il conseguente decollo), e questo per una ragione fisica facilmente comprensibile. Sappiamo, infatti,
che l'aria deve gonfiare la vela entrando attraverso le bocche e distribuirsi, poi, attraverso i fori delle centine.
Questo avviene soltanto se la prima parte di vela che si gonfia è quella centrale: le parti laterali vengono
sollevate passivamente (anche sgonfie) e la completa apertura è assicurata dai fori di cui sopra.
Se, al contrario, si gonfiano per prime le parti laterali, esse si sollevano e convergono verso il centro, facendo
collassare la bocche della parte centrale: il risultato è che la vela si accartoccia senza mostrare alcuna
tendenza ad assumere la configurazione di volo.
Dal momento che il gonfiaggio viene effettuato dal pilota trazionando gli elevatori anteriori è necessario che questi agiscano prima sulla parte centrale che su quelle laterali. In altre parole la parte centrale deve essere più distante dal pilota rispetto alle parti laterali: questo si ottiene disponendo la vela a semicerchio (o "a ferro di cavallo"), con le bocche centrali bene aperte (Fig. 6-6).
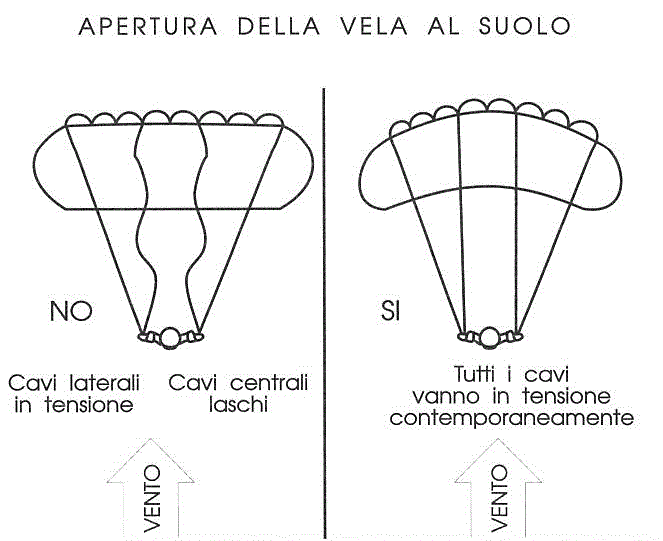
Figura 6-6. I primi cavi ad entrare in trazione devono essere quelli centrali: disporre la vela a "ferro di cavallo".
Proprio sul campetto, dove le possibilità di errore dovrebbero poter essere ampiamente "perdonate", è
indispensabile prendere l'abitudine di verificare con attenzione la vela stessa e, soprattutto, la disposizione dei
cavetti e dei freni.
I cavetti devono essere tutti "a vista" (nessun cavetto deve passare tra vela e terreno) e privi di nodi o grovigli:
particolare attenzione andrà rivolta ai cavetti laterali che, anch'essi, devono giacere sopra agli
stabilizzatori, e non essere, invece, nascosti da questi.
I cordini dei freni dovranno essere disposti sul terreno, più esternamente rispetto a tutti gli altri,
in modo da poterne verificare completamente il decorso.
Quando, come accade sovente nei campi scuola, la selletta viene mantenuta costantemente attaccata alla vela, può
accadere che essa compia uno o più giri su sè stessa: prima di "indossarla" è dunque indispensabile
verificare che sia correttamente allineata.
Per fare ciò si solleva la selletta tenendola per i cosciali; l'altra mano scorre, sempre a contatto con i
materiali, partendo da sotto alla selletta, passando sui fianchi delle fasce, risalendo fino ai moschettoni: a questo
punto la mano deve trovarsi sulla faccia anteriore degli elevatori anteriori; se i cavi che partono dagli elevatori
anteriori raggiungono il bordo di entrata della vela senza "attorcigliarsi" con i cavi posteriori, possiamo essere certi
che la selletta e correttamente posizionata. Altrimenti sarà necessario farla girare su sè stessa e ripetere
la manovra di controllo.
L'allacciatura alla selletta deve essere effettuata avvicinandosi di qualche metro alla vela stessa: altrimenti le
ripetute trazioni sui cordini rovineranno completamente l'attento lavoro di disposizione della vela al suolo prima
effettuato. Soltanto al momento del gonfiaggio si deciderà, in base alla forza del vento, quale distanza deve
effettivamente essere presa rispetto alla vela. A questo punto si infilano le spalline e si fermano i tre punti di
aggancio: i due cosciali ed il pettorale, verificando la giusta posizione e la tenuta delle fibbie di sicurezza.
è opportuno fare subito una piccola distinzione tra questi tre punti: i due cosciali sono punti
fondamentali, nel senso che sono loro a mantenerci "attaccati" alla vela, ed un loro errato aggancio (con cedimento
od apertura in volo) è indubbiamente drammatico.
Il pettorale, invece, ha una funzione meno "vitale" anche se importante: esso impedisce un eccessivo allontanamento degli
elevatori (destri e sinistri) che vengono trazionati, non soltanto verso l'alto ma anche verso l'esterno, dai fasci
funicolari.
Il mancato aggancio del pettorale è ancora compatibile con un volo "controllabile", ma la sensazione di "cadere
in avanti" è, specie agli inizi, molto spiacevole ed angosciante, anche se le spalline, di fatto, impediscono che
questo avvenga.
Questa operazione presenta, inizialmente, una difficoltà notevole, ma diviene rapidamente automatica quando si
adotta un "sistema" standard.
L'importante è che le nostre mani impugnino i freni e gli elevatori anteriori mentre gli elevatori posteriori
giacciono sugli avambracci (Fig. 6-7).
Raggiunta tale posizione si verifica, sollevando le braccia ed allontanandosi leggermente dalla vela (occhio a non
"scompigliarla"), che i cavi anteriori siano completamente liberi lungo tutto il bordo di attacco.
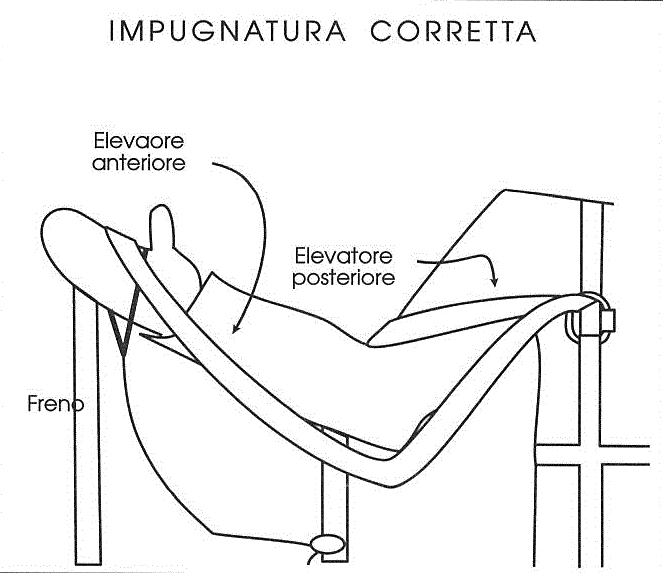
Figura 6-7. Impugnatura corretta: l'elevatore posteriore passa sopra all'avambraccio
Iniziando ad avanzare controvento, con una corsa progressiva, si compie un ampio movimento con le braccia, trazionando
gli elevatori anteriori in avanti e verso l'alto: la vela, gonfiandosi, oppone una certa resistenza fintantochè
è dietro di noi; poi, dopo una rapida salita, raggiunge la nostra verticale e, se glielo consentiamo (ad esempio
rallentando la corsa, oppure tirando verso il basso gli elevatori anteriori che teniamo in mano), ci supera per
afflosciarsi subito dopo.
Il secondo obbiettivo, una volta in grado di gonfiare la vela, è quello di raggiungere e mantenere l'assetto
di decollo, cioè correre per alcune decine di metri (su un terreno pianeggiante) mantenendo la vela sulla
verticale: perchè questo sia possibile è necessario che la nostra velocità sia uguale alla velocita
di volo della vela stessa. Mentre è intuitivo che possiamo accelerare o frenare la nostra stessa corsa, è
meno immediatamente evidente che, tramite i freni, possiamo accelerare o frenare anche la velocità
della vela.
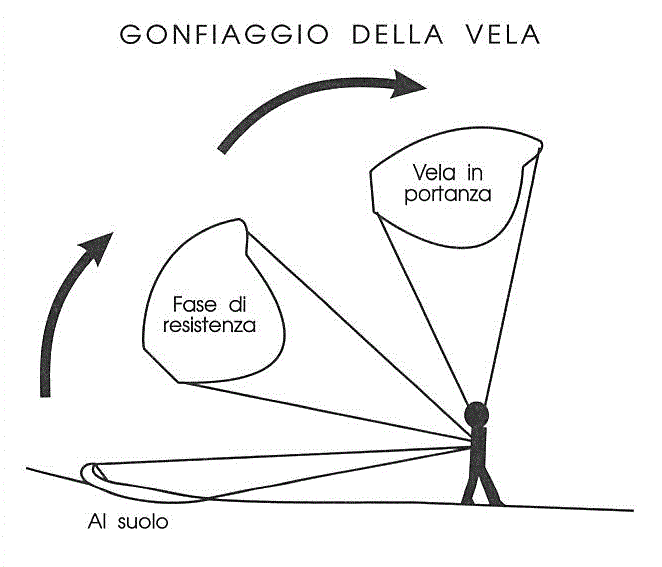
Figura 6-8. I due momenti del gonfiaggio: bisogna essere pronti a "vincere" la fase di resistenza.
Una volta terminato il gonfiaggio (anzi, qualche attimo prima che la vela sia sulla verticale), abbandoniamo gli elevatori anteriori ed abbassiamo leggermente i freni, proseguendo la corsa. Se la vela tende a sopravanzare, acceleriamo la corsa e, contemporaneamente, trazioniamo maggiormente i freni. Se la vela rimane indietro, rallentiamo per un attimo, rilasciando completamente i freni; in alcuni casi, se la vela tende a "cadere all'indietro" può essere necessario riprendere gli elevatori anteriori e ripetere la fase di gonfiaggio esercitando, come prima, una trazione verso l'alto ed in avanti (mai verso il basso) (Fig. 6-9)..
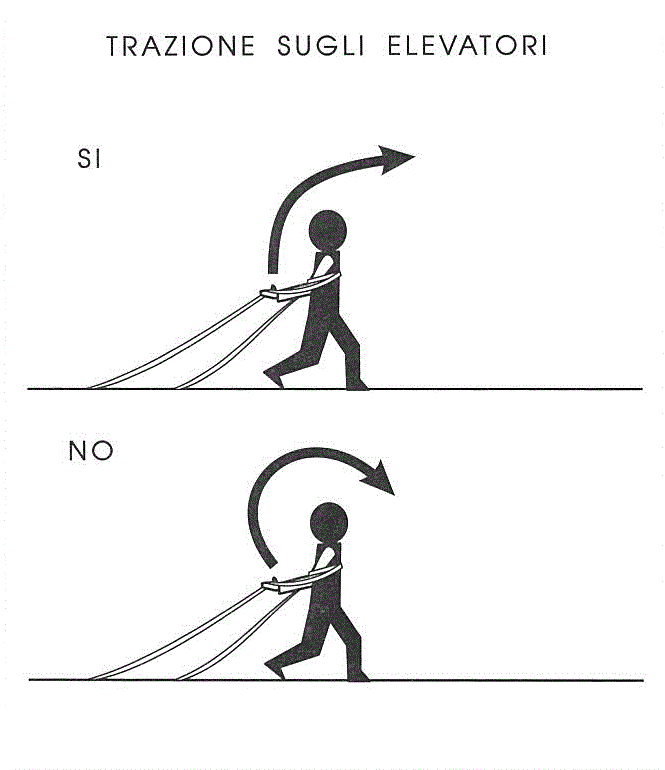
Figura 6-9. La trazione sugli elevatori deve essere rivolta in avanti ed in alto.
Esaurito lo spazio disponibile è ora necessario fermare la vela che, idealmente, deve adagiarsi al suolo dietro di noi senza eccessivi ingarbugliamenti dei cavi: questo viene ottenuto frenando completamente la vela (freni ad altezza natiche) e continuando ad avanzare; se ci si ferma troppo presto, la vela scende sulla nostra testa, legandoci con i suoi cordini (Fig. 6-10).
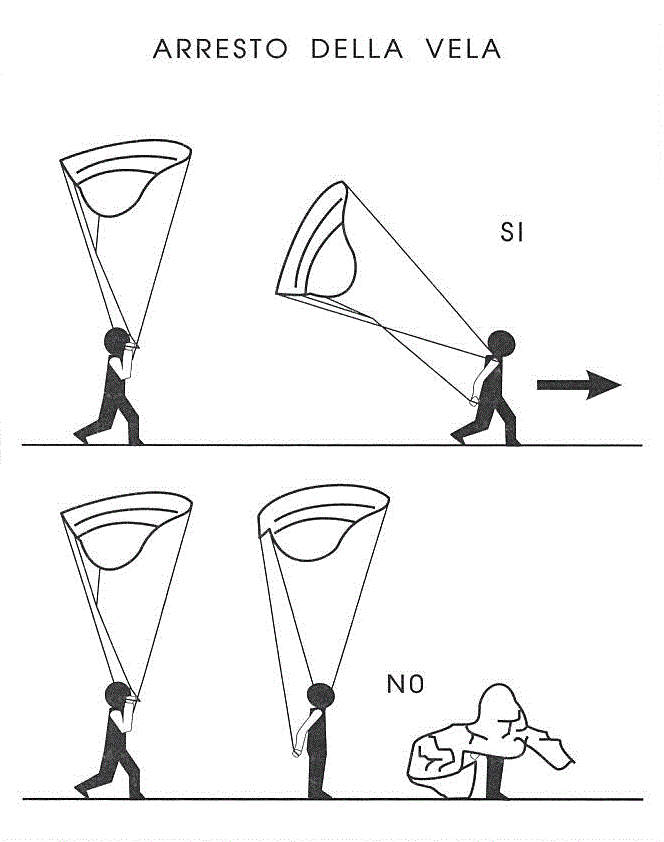
Figura 6-10. Per arrestare la vela è necessario frenarla e, contemporaneamente, avanzare con il corpo.
Un errore molto frequente (quasi costante!) consiste nel trazionare verso il basso gli elevatori anteriori
(appendersi agli elevatori): il risultato immediato è che la vela accelera, ci supera, e si affloscia davanti a
noi o sopra di noi. Deve infatti essere chiaro che, quando la vela è dietro di noi (mentre si stà gonfiando)
una trazione sugli elevatori corrisponde ad una trazione in avanti della vela, mentre quando questa è sopra
di noi, la stessa trazione diviene una trazione verso il basso di tutto il bordo di attacco, il che, come sappiamo
dalla aerodinamica, si traduce in una riduzione dell'angolo di incidenza ed in una accelerazione.
Per evitare tale errore è utile suggerire all'allievo di aprire le mani (badando a non lasciare andare i
freni), non appena la vela ha iniziato a sollevarsi. Con gli elevatori anteriori che appoggiano sui palmi delle mani
è ancora possibile spingerli in avanti, ma è invece impossibile tirarli verso il basso.
Un secondo errore, ma sarebbe meglio definirlo un'insieme di errori, consiste nel correre in modo disordinato, agitando
le braccia (che reggono i freni) per aiutarsi a mantenere l'equilibrio. Sui campetti (e purtroppo non solo lì)
se ne vedono di tutti i colori: corse con le braccia allargate ad aereo (quasi dovessero essere loro le nostre ali) che
oscillano paurosamente a destra ed a manca. Salti e ricadute che aggiungono e tolgono peso alla vela, impedendole di
stabilizzarsi. Improvvise frenate ed accellerate.
La vela è molto leggera e, per volare, richiede una corsa ed un carico più uniformi possibile. Ogni
"strattonata", modificando la forma, ne interrompe l'involo, e l'allievo corre, corre, senza che essa mostri alcun
desiderio di stabilizzarsi su di lui.
La corsa in assetto di decollo deve invece essere lineare, le braccia ripiegate mantengono i freni all'altezza delle
orecchio, i gomiti a contatto con il corpo impediscono movimenti disordinati, la velocità non subisce brusche
variazioni.
Già durante le corse in piano è utile "saggiare" l'effetto dei singoli freni sull'ala, trazionando ora l'uno ora l'altro e correggendo anche la traiettoria di corsa per mantenere l'ala sempre sulla verticale (Fig. 6-11).
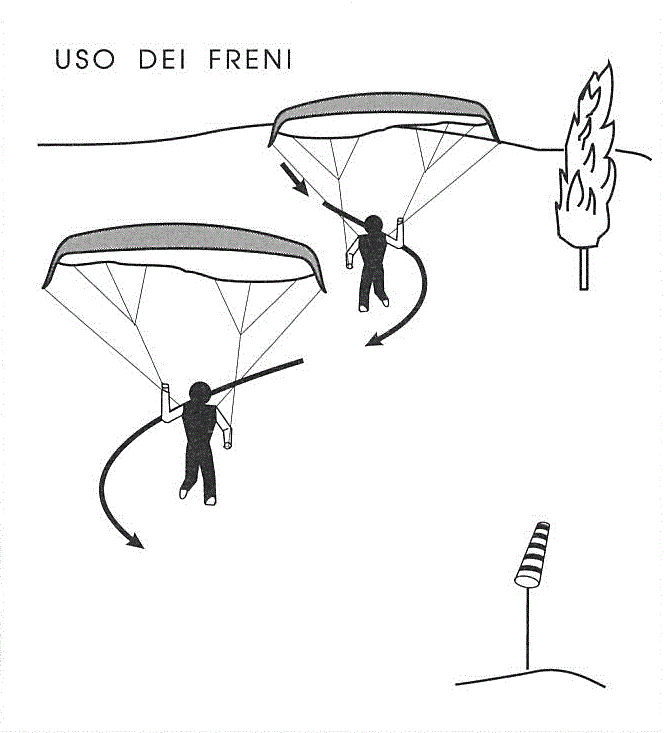
Figura 6-11. Anche correndo sul prato è possibile pilotare la vela agendo sui freni: è molto utile saggiarne la risposta fin dai primi esercizi.